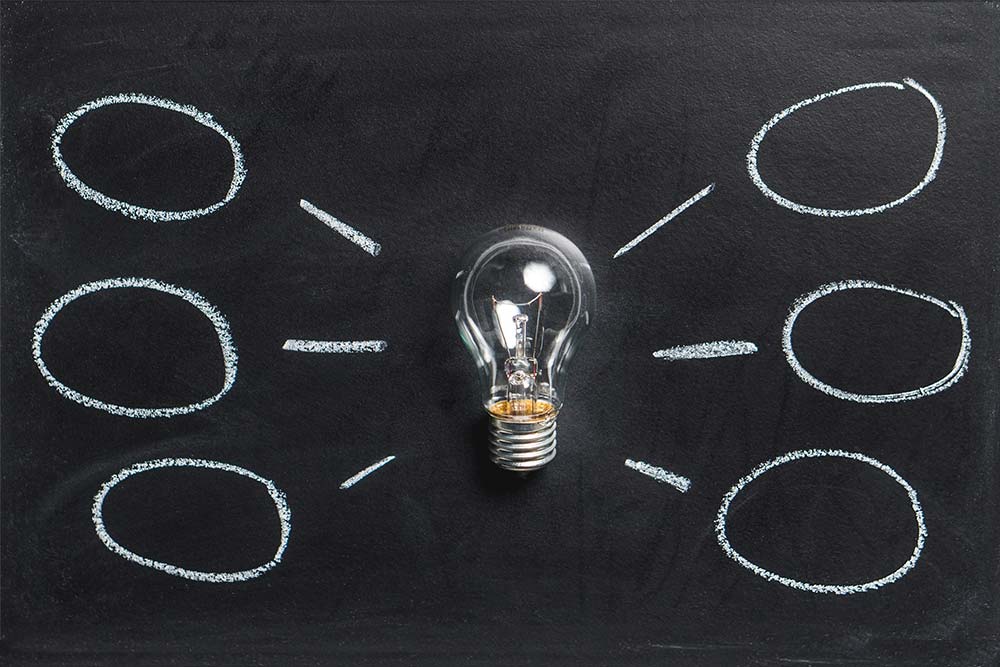La parola “intelligenza” è senz’altro legata a uno dei primi giudizi di valore che incontriamo nella nostra vita: ad essa associamo la velocità con cui un bambino impara a camminare o a parlare, e sappiamo che quando poi comincia il percorso scolastico il rendimento è spesso imputato all’intelligenza dell’alunno, come se dietro tale parola si celasse una generica abilità che favorisce il successo in qualunque compito cognitivo. Di fatto è proprio questa l’idea che sta dietro la prima definizione di intelligenza: nel 1904 Charles Spearman teorizzò che l’intelligenza fosse riconducibile ad un cosiddetto “fattore G”, che stava alla base della capacità di risolvere problemi e compiti intellettivi di qualunque natura.
Tale visione ha influenzato anche i tentativi di misurare l’intelligenza, come testimoniato dal ben noto concetto di quoziente intellettivo (QI). Il QI ha infatti origine dal tentativo di elaborare uno strumento per individuare fin da subito quegli studenti che, per il sistema scolastico francese dei primi del ‘900, erano considerati troppo lenti per beneficiare di un normale iter scolastico dopo l’istituzione della scuola dell’obbligo. Il test di Stanford-Binet (ovvero il primo test del QI, edito nel 1905) si basa sull’idea di età mentale: quanto più in alto un bambino riesce a collocarsi sulla scala, tanto più elevata è considerata la sua età mentale (EM). L’età mentale viene poi rapportata all’età cronologica nella ben nota formula: “età mentale/età cronologica x 100”.
Ma l’intelligenza è davvero pensabile come una singola abilità latente che sta alla base di qualunque abilità cognitiva?
Anche se quest’ultima idea è tutt’ora dominante nell’immaginario comune, non sono mancati, sin dai primi tentativi di misurazione del QI, punti di vista molto diversi.
È il caso di quelle teorie che tentano una descrizione più complessa delle caratteristiche di questo costrutto, presentandolo come formato dall’interazione di diverse abilità, indipendenti tra loro. Considerare l’intelligenza come derivante da diverse abilità di ordine e importanza differente consente di capire perché ci sono situazioni (come i disturbi dell’apprendimento, e deficit dell’attenzione) in cui solo alcune abilità sono compromesse, mentre altre risultano integre.
Ancor più distanti dall’idea di fattore G, è poi le teoria delle intelligenze multiple, alla base della quale c’è una riflessione di carattere sociale: il contesto socio-culturale entro cui sono nati i tentativi di definire e misurare l’intelligenza, hanno dato maggiore peso scientifico solo alle abilità linguistico-verbale e logico-matematiche, trascurandone altre, più evidenziate in culture diverse. La teoria delle intelligenze multiple, infatti, accanto all’intelligenza linguistico-verbale e a quella logico-matematica, considera altre 7 tipologie di intelligenza.
Questo breve excursus non può certo evidenziare limiti e possibilità di ogni definizione e di ogni modello preso in considerazione per discutere di intelligenza, tuttavia risulta utile per sottilineare come il cambiamento del punto di vista con cui si guarda ai costrutti psicologici porti a delle conclusioni molto differenti. Una parola come “intelligenza”, che viene inizialmente utilizzata per riferirsi a qualcosa che si ritiene chiaro e misurabile, vista con differenti premesse diventa un concetto molto meno monolitico.
Dott. Francesco Colombo